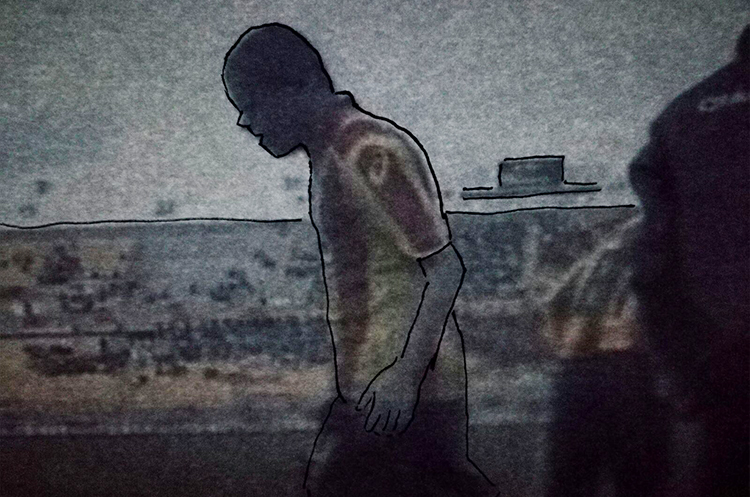Il natale arriva e lascia vittime sepolte ogni anno nell’erba finta del presepe.
Carta regalo strappata con violenza, spiegata con metodo, da dita esperte, avide di attenzioni, tensione senza curiosità, gesti compulsivi e concentrazione su come mascherare la propria delusione di fronte all’ennesimo maglione marrone, allo sciarpone vinaccia, bello caldo, cento per cento acrilico. Eppure, di fronte ai risultati negativi, ai bilanci in rosso, alle sconfitte reiterate, ai moduli che cambiano freneticamente senza che nessuno riesca a trovare il bandolo della matassa, ecco che puntualmente nasce il bambinello, il Salvatore. Al suo fianco, accosciati, il padre-allenatore e la madre-moglie-agente che presentano il nuovo arrivato. Alle loro spalle, la squadra, gli animali, il bue, l’asinello e chissà quante altre bestie ignorate dai racconti frammentari degli evangelisti e degli apocrifi. Simboli di una società contadina, abitudinaria, forte ma non abbastanza da potersi salvare da sola.
C’è bisogno di un grande acquisto. Il Presidente sornione tra le nuvole apre il portafogli e concede il nome alla piazza, nella speranza che serva, che almeno questo possa placare i tifosi. I tifosi infatti arrivano, a frotte. Li si vede nel presepe: il pescatore, il calzolaio, i pastori imberbi, le ancelle, la povera gente, la pancia del popolo, senza distinzione di sesso, età, conto in banca. Tutti a vedere il nuovo acquisto. I pastori continuano ad affollare la radura davanti alla grotta, i parenti riempiono la sala di profumo e sacchettate di regali. Foto, luci a intermittenza, carta crespa che simula montagne, cespugli, natura finta. La scenografia fittizia è ideale per rinnovare qualcosa di vecchio, ogni anno.
Arriva anche la stampa, un po’ in ritardo, che segue la stella cometa. E quando ormai la notizia è già moda ecco che arrivano i Magi, a portare i doni, l’adulazione, il tu informale, la provocazione. La squadra è in zona retrocessione, lo si poteva prevedere, lo si poteva temere, lo si poteva evitare. Ma tant’è, ora è lì e qualcosa bisogna fare nella cosiddetta finestra del mercato di gennaio. Serve proprio un Salvatore per raggiungere l’insperata Salvezza.
Solo che non si vede bene. Sarà la luce della notte dei tempi, troppo bassa per i tempi. Non si riesce a capire chi sia questo Salvatore. Bello o brutto? Biondo o moro? Vero o falso? Perché il presepe sarà anche perfetto, ma l’erba è finta, il laghetto è un’allusione filosofica, in realtà è solo un pezzo di carta stagnola, e il padre-allenatore non è il vero padre (e non è detto che sarà il suo allenatore per tutta la stagione). È putativo, dalla notte dei tempi. Troppi dubbi dietro quella maglietta mostrata ai pastori, troppo buia la notte, troppo misteriosa. Aspettiamo di vederlo in campo, questo Salvatore, e vediamo che faccia ha davvero.
E se salvezza sarà.
L’Ariete sacrificale
Può capitare che il Salvatore abbia molti muscoli, carne in abbondanza, mascelle bloccate, sguardi poco intelligenti. In alcuni casi, questi tratti somatici, uniti ad immagini sfocate in vhs di colpi di testa grosso modo indirizzati nello specchio della porta ma in campionati esotici, ed esultanze che mostrano denti bianchi e cavallini, sono un biglietto da visita per entrare nel cuore dei tifosi delusi e a caccia di emozioni nuove. Questa tipologia di Salvatore incarna non l’uomo forte ma quello forzuto, che apre non la portiera della macchina ma la bottiglia di vetro che sembra impossibile da stappare, che con un colpo ben assestato forza la porta quando ci si dimentica le chiavi di casa, anziché prevenire l’evenienza e lasciarne un altro paio altrove.
Un Ariete, insomma, ma non un Ariete qualsiasi: è un Ariete Sacrificale, un monumento al tentativo, il manifesto artistico dello sforzo, l’eroe che viene per cambiare il destino dei non eroi, o meglio che ci prova.
E come si chiama? Si chiama Roberto Nanni, per esempio. Anno 2005/2006, il Messina è terzultimo e teme il peggio. Zampagna sceglie l’Atalanta e Iliev il Genoa, l’attacco, senza neppure dare particolare rilievo all’addio di Yanagisawa, è sguarnito. Arriva un ragazzo di belle speranze, Floccari, che si farà apprezzare più per tecnica e generosità che per la sua vena realizzativa. Ma soprattutto, appunto, Nanni, argentino di nascita, di proprietà della Dinamo Kiev, ma girato in prestito al Siena che gli aveva regalato pochi scampoli di partita, ora finalmente al Messina potrebbe farsi valere, vista la scarsa concorrenza. Ma i pastori tifosi dovranno aspettare marzo per godere della sua prima gioia: Nanni segnerà la rete decisiva contro il Lecce, poco dopo essere subentrato a re Artù Di Napoli, proprio su assist di Floccari. La più bella partita per gli uomini guidati da Bortolo Mutti sarà però una favola da raccontare ai nipoti dei pastori: il tridente Bondi-Nanni-Floccari costringe la Juventus a un pirotecnico 2-2 con doppietta di Floccari (l’unica). Nanni sembra un lottatore nato, solo per un pomeriggio. Il Messina retrocederà sul campo, ma la squalifica della Juventus con relativa retrocessione concederà ai siciliani una imbarazzata e tutto sommato insperata salvezza.
E se non fosse Nanni questo energumeno? Se si chiamasse invece Milton, Milton Caraglio? Dovremmo andare al 2012/2013, allora, in tempi dunque molto più recenti, quando un Pescara persino più disastroso di quello che nella corrente stagione imbarca goleade e si espone alle peggiori figure ritenne di dover acquistare da una squadra cilena la punta originaria di Rosario concedendogli, a 25 anni, la grande occasione di irrompere nel mondo della serie A e, perché no, del calcio europeo. Un’occasione rosicchiata, in realtà, con appena quattro presenze in campo, due delle quali per novanta impalpabili minuti. Caraglio, struttura fisica possente, da toro più che da ariete, assediato, più che assistito, da Celik e Caprari, non segnerà mai. Timido come un brutto sogno, sparirà dimenticato, e oggi corre in Messico nel Tijuana, lontano anni luce dall’Abruzzo amaro.
E se, a guardar bene, si trattasse invece di Christian Stuani? Vorrebbe dire che quegli occhi innocenti e spenti di Ariete li avremmo già incrociati nel 2007/2008, con la maglia di una Reggina penultima. Ulivieri afferra questo ragazzone che viene dal Danubio uruguagio e lo butta in campo per dodici volte. Pur scrollandolo ripetutamente, fino a fargli battere i denti, neppure un centesimo di gol gli cade dalla tasca, e saranno Amoruso, Brienza, uno sbalorditivo Cozza, Missiroli e una difesa composta dai camerieri da sala ricevimenti Lanzaro-Modesto-Aronica a salvare la Reggina.
Sarà una stagione strana quella, l’unica in cui le tre squadre che occupavano la zona retrocessione nella pausa natalizia si sono tutte salvate. Una stranezza che riguarderà anche il Siena che, per ironia della sorte, come si dice, può mostrare orgogliosamente il suo Ariete Sacrificale di fiducia, Richard Porta, pure lui deportato da una gloriosa squadra urugagia, il River Plate, per illudere i tifosi e lanciare la promessa di una salvezza conquistata a suon di gol sudamericani. Il lungo centravanti correrà per ventotto interminabili minuti in una sconfitta per 4-0 proprio contro la Reggina (ma Stuani era impegnato a riflettere in panchina).
Poi più nulla per Porta. Eppure, il Siena resta a galla e brillantemente.
Retrocederà invece un Empoli che, forte di una partecipazione alla Coppa UEFA e con la banda Buscè, Vannucchi, Giovinco, Marchisio, non ritiene di dover sostituire in alcun modo Eder in attacco, preferendo assicurarsi le prestazioni di un Budel; retrocederà il Livorno che di fronte agli occhi sornioni dell’attaccante spagnolo Tristan che davvero chiedeva solo ancora un po’ di pazienza, e forse di affetto, non ebbe il cuore di rimpiazzarlo e, salutati Dhorasoo e Danilevicius, pensa di star bene così.
Retrocederà anche il Parma, che pure non sembrava così malato e che pure a gennaio investe su un attaccante prestigioso, di quelli che entrano e salverebbero chiunque fosse in pericolo, dando poi il merito non a sé ma al gruppo: Cristiano Lucarelli, il vigile del fuoco ideale, un Ariete a suo modo, ma che porta con sé una storia diversa da raccontare a parte.
Cercasi bomber con esperienza
Questo è davvero il grande classico del presepe del mercato di gennaio. Il veterano, la cariatide, l’esperto, il bollito, l’attaccante a fine carriera non ha più nemmeno un nome, neppure il ricordo delle sue imprese lo salva, è un “vecchio” e come tale si carica la squadra sulle spalle, con effetti patetici, più Antico Testamento che Bruce Willis. Il “vecchio”, nessuno lo tocchi, considera sufficiente battersi come un leone, caricare i più giovani, urlare ai compagni di reparto, applaudire con dignità a chi gli ha fatto un passaggio dopo aver egli stesso, però, sbagliato lo stop. Il bomber con esperienza sbarra i suoi occhi cupi sul panorama desertico che lo circonda, si toglie la corona dal capo e il mantello e comincia a giocare. Ama fare a sportellate e sistemarsi i calzettoni dopo uno scontro. Ma i risultati non sono un granché.
Lo avrà pensato anche Cristiano Lucarelli, in quel famoso 2007/2008, prelevato dal Parma, con lauto esborso – cinque milioni – dallo Shaktar Donetsk, fresco di esperienza internazionale, condita da presenze e gol in Champions League. Il suo ritorno in A, dalla porta posteriore, è accompagnato dalle fanfare della leggenda, un cavaliere senza macchia, un professionista delle piccole squadre, allergico alle vette. Eppure, favole a parte, il Parma continua a inabissarsi, lentamente e inesorabilmente. E il bomber con esperienza Lucarelli rimedia solo 4 gol in 16 presenze. Un gol ogni 4 partite non è poco, ma è pochissimo, in confronto al meno quotato compagno di squadra Budan che ne avrà totalizzati 7. Ed è davvero un’inezia, se non un danno, di fronte ai punti insufficienti complessivi che condanneranno il Parma alla retrocessione.
Affossando le guance di Lucarelli, allungandogli inverosimilmente la forma del cranio e cambiandogli quasi del tutto i connotati, si può ottenere un bomber con esperienza totalmente diverso, ammantato di storia, ormai molto lontano nel tempo, quasi come parlare di Numa Pompilio ai tempi di Caligola: è Marco Delvecchio, nel 2004/2005. Arriva a gennaio dalla Roma per cercare di salvare il Brescia, in zone paludose. I piani della bonifica salteranno, cinque presenze, nessun gol, le rondinelle (che fanno esordire un diciassettenne Marek Hamsik) retrocedono e Delvecchio, bomber con esperienza, inizia il lento declino da attaccante mite e paziente, spesso sfruttato dai suoi allenatori ma forse mai capito a sufficienza, nel silenzio educato di chi accetta più facilmente il pallone che esce di poco di quello che si infila sotto la traversa.
Ma se la testa invece fosse quella di Bellucci al Livorno nella stagione 2009/2010? Sarebbe quella dura di una seconda punta cocciuta e introversa, con un talento balistico raro e un’autostima bassissima. Forse non si piaceva, Bellucci, nonostante fosse pregevole, forse non è stato così pregevole perché alcune volte si piaceva troppo, fatto sta che approdato al porto di Livorno a 35 anni per salvarlo finisce per segnare solo un gol, bellissimo, in una vittoria calda come il sole che batte sul Picchi, in pieno aprile. Un tiro al volo all’incrocio dei pali, su torre proprio di Lucarelli, colpito con la pienezza dei veri centravanti e l’effetto dei subdoli fantasisti. Bravo Bellucci, ma il Livorno retrocede e la fine della carriera è vicina.
E se invece da una testa ne spuntano due e una mostruosa separazione cellulare sconquassa il corpo del bomber con esperienza, regalando ai pastori e ai tifosi l’ebbrezza addirittura di un bomber con esperienza più una agile spalla, come una moto con sidecar, l’entusiasmo può essere irrefrenabile. Basta chiedere conferma ai due casi storici di coppie comiche arrivate insieme, a braccetto, nei mercati di gennaio di qualche anno fa.
Anno 2011/2012, il Novara colto in flagrante in zona retrocessione nella pausa natalizia arriva alla conclusione che l’anno vecchio è finito ma qualcosa ancora qui non va. Meggiorini, cavallo rapido dal futuro promettente, sceglie con estrema intelligenza di allungarsi la carriera passando al Torino in serie B. Anche se Morimoto e Rubino non costituiscono motivo di fiducia per sperare in una salvezza. Nella culla si materializzano due straordinari esponenti del mercato di gennaio, Mascara e Caracciolo, uno meridionale, l’altro settentrionale, uno basso, l’altro alto, uno ispiratore, l’altro finalizzatore. Un destino irrinunciabile li metterà uno di fianco all’altro in quello che, a oggi (Mascara si è ritirato, ma Caracciolo gioca ancora), resta il loro ultimo anno di Serie A in carriera.
Non faranno ridere, forse anche per l’intervento del terzo incomodo, Jeda, che conquisterà spesso un posto da titolare. Ma Mascara e Caracciolo giocheranno, rispettivamente, 16 e 19 partite, non poche, segnando 3 gol il primo e 2 gol il secondo (uno dei quali decisivo nella storica vittoria del Novara a San Siro contro l’Inter, in quella che nelle interviste dopo partita l’allenatore sentimentale Mondonico definirà un’impresa paragonabile ad aver vinto “il festival di Sanremo”). Il Novara, senza troppi disturbi, retrocede.
Stesso anno, 350 km di distanza: a Cesena il tridente Mutu-Candreva-Eder non gira, la dirigenza decide che bisogna cambiare ed ecco che, come evidentemente va di moda quell’anno, la scelta ricade su altri due giocatori polverosi, più simili a ex carcerati che a innocenti pensionati, con tantissimi dubbi di ricadute (fisiche) imminenti, ma dai nomi altisonante l’uno, esotico l’altro: Iaquinta e Santana. Appena arrivati perderanno insieme, inseparabili, quattro partite consecutive, l’ultima delle quali schierati fianco a fianco in attacco (un irreprensibile 0-2 dalla Fiorentina). Poi un lungo stop per il campione del mondo, Santana invece resisterà con ottimo minutaggio e tempra da cattivo tenente. Alla fine non sfigurerà, con 3 gol e 2 assist. A Iaquinta il bel sogno di un gol all’esordio, poi più nulla e novanta minuti contro l’Inter, per chiudere così la strampalata e irreale carriera in A di uno di quei vincenti che collezionano ricordi perché temono che un giorno nessuno crederà alle loro storie.
Ovviamente, anche il Cesena retrocede.
Largo ai giovani
Ci sarebbero anche i giovani, che più si addicono al ruolo di Bambinelli. Ma le loro storie sono perfide, intrise di un opportunismo odioso, sono gesù antipatici e cattivi che sanno bene che un mercato di gennaio è solo un’occasione, una delle tante.
Borriello a Treviso nel gennaio 2006, a 24 anni, mostra tutta la sfrontatezza delle punte emergenti, sedotte ogni estate dal Milan ma poi costrette a girare in provincia per conquistarsi una fetta di futuro. Con la maglia della Samp stentava e allora meglio andare dove è davvero impossibile perdere il posto da titolare, il luogo ideale per essere considerato un trascinatore. In realtà non andrà poi così bene: tre lunghi mesi con solo un gol all’attivo. E poi improvvisamente 4 gol nell’ultimo mese. Sospetti maligni: sembrerebbe il tipico ruolino di marcia di chi non ha affatto a cuore la salvezza della propria squadra ma fa di tutto per mettersi in vetrina, guarda caso a fine campionato, a ridosso di maggio. Il Treviso retrocede. Appena un anno dopo Borriello, dopo una stagione trionfale al Genoa, vedrà sestuplicata la propria quotazione sul mercato e otterrà di diritto il suo Milan.
Di giovani inespressi è lastricata la via del mercato di gennaio, giovani su cui si esercita una pressione troppo schiacciante, e questi ragazzi, nascosti nella mangiatoia, cullati dal buio e dal gelo di una notte invernale, possono chiamarsi, tra i molti altri nomi che potrebbero avere, Okaka Chuka, di passaggio al Bari nell’annus horribilis di Ventura, 2010/2011, autore del gol decisivo nel derby contro il Lecce all’esordio, il 6 gennaio. Sparirà dai tabellini per rientrare solo in un’altra occasione, finisce per alternarsi tra campo e panchina, poi si fa male e l’altalena si ferma. Il Bari retrocede: è passato molto tempo dal gol di Okaka contro il Lecce e non se ne parli più.
E di certo se il nome fosse quello di Ante Rebic, il Verona del 2015/2016 si sarebbe legittimamente aspettato di più, vedendolo arrivare dalla Fiorentina circondato da un alone di talento e nobiltà, un principe di Spalato che non si degna però di segnare neppure un gol, complice la discontinuità nel suo utilizzo, ma anche quella presunzione che si diceva prima, tipica di chi sa che non è certo la sua ultima chance. Rebic oggi gioca in Bundesliga, il Verona è in B che lotta per tornare in massima divisione.
Ma spesso il calcolo è sbagliato, sperare di rifarsi da un’esperienza negativa, proiettandosi in uno dei tanti futuri che ci si immagina, non è una prospettiva che vale per tutti. Per esempio, Federico Macheda, il gesù più doloroso, il più fallimentare e quindi forse il più puro. È una crisalide ormai vuota dal 2010/2011 e difficilmente ci si ricorda dei suoi movimenti, dei suoi tentativi di guadagnare spazio o di puntare l’uomo o di tagliare sul primo palo. Col passare del tempo, nessuna di queste caratteristiche sembra connotarlo più di altre. La figura di Macheda passa dai furori delle critiche positive, quando era una promessa del Manchester United, al silenzio tombale che cresce di partita in partita mentre le promesse affondano davanti al pubblico basito della Sampdoria, una squadra già provata dall’eliminazione in extremis in Champions e dalle cessioni, ritenute indispensabili, di Cassano e Pazzini alle milanesi. Macheda sente che sta per arrivare il suo momento di esplosione o implosione e tergiversa, traccheggia, esita. Da quei cinque mesi del 2011, con zero gol all’attivo e una sola partita da titolare per novanta minuti, Macheda non ha più visto la Serie A. La “sua” Sampdoria, senza più un briciolo di energie nervose, sfibrata e smarrita, retrocede.
Blasonati, brasiliani, ma comunque evaporati
Succede anche che la squadra non giri. I più accorti sanno che se non gira è perché mancano i rifornimenti. Un uomo di lotta e di governo, possibilmente, che sappia gestire il pallone, con passaggi semplici, lineari e, possibilmente, improvvise verticalizzazioni a cercare le punte sorprendendo le retroguardie avversarie. Ovviamente se fosse possibile anche una tempra da lottatore e una tendenza, come si suol dire, a “non mollare mai”, sarebbero l’ideale. Per due volte tra il 2004 e oggi, le squadre in lotta per la salvezza finiranno per fare del nuovo centrocampista l’acquisto più importante del mercato invernale, trascinandosi su questi identikit illusori. La realtà invece è un accozzaglia casuale di momenti opachi, di fronte ai quali davvero si ha il dubbio se proseguire a far luce su di essi oppure lasciare che la selezione naturale continui a decidere per tutti.
Eppure com’è speculare e malinconico l’arrivo in momenti diversi di Edinho e Ibson. Il primo nel 2008/2009 scivola sensuale sotto la maglia del Lecce, con delicatezza pari al velluto della sua decantata regia. Edinho effettivamente arriva dall’Internacional, ci vogliono degli assegni importanti per acquistarlo, ha vinto una Libertadores e un Mondiale per club e da uno così ci si aspetta tutto il fosforo della zuccheriera più pregiata. L’allenatore dal volto umano Mario Beretta lo fa debuttare nel secondo tempo di un’insperata vittoria sul campo del Siena, per coprirsi un po’. E immediatamente Edinho s’inserisce nel campionato italiano, travestendosi da oggetto anonimo, senza alcun acuto. Rotea il pallone, distribuisce, imposta, lancia e cuce, e a ogni tocco sparisce un po’ di più. Al 65° dell’ultimo tracollo fuori casa contro il Genoa, Beretta lo toglie, gli sussurra due parole ed Edinho nemmeno si siede in panchina, si dissolve, educatamente, diventa aria, mentre il Lecce, comodamente ultimo, retrocede. Le cronache e le statistiche riferiscono di un Edinho in versione 2016/2017 che continua a fare il suo dovere in patria, tra Coritiba e Gremio, va in campo regolarmente e nessuno gli ricorda del suo passato, di quando ha provato a fare il Salvatore a Lecce, senza riuscirci.
Il secondo, brasiliano come il primo, e vorrà dire qualcosa, è arrotolato negli annali del 2013/2014, e viene acquistato quando il Bologna è quart’ultimo, appena salvo, ma senza potersi godere la sacra rappresentazione natalizia. Anche in questo caso il fardello scaldato dal bue e dall’asinello è un ragazzo scuro di nome Ibson, due volte campione del Portogallo con il Porto e una volta col Flamengo in Brasile, titolare nei gironi di una Champions League nello Spartak Mosca agli ordini di mister Massimo Carrera. E persino otto minuti in finale di Mondiale per club con la maglia del Santos al fianco di Ganso e Neymar e contro il Barcellona di Messi.
Assaggi di grande calcio. Poi i suoi contatti lo portano a Bologna in quella che, a detta di tutti, si chiama ancora Serie A. Ma la salvezza non è come lo scudetto, benché ne condivida l’iniziale. E Ibson, ben più che regista, vero e proprio trequartista, non trova spazio se non per manciate di minuti. Ben che vada ne colleziona 77 in uno 0-0 contro il Sassuolo, in cui vede per gran parte del tempo gli altri sfrecciare intorno a lui, prima di farsi incontro, misteriosamente, a un giovane con i capelli lunghi e legati da una cordicella, che gli tende la mano. È fuori dal campo, ma vuole entrare e, a quanto pare, sarà proprio lui, Ibson, a lasciargli il posto. Lo fa senza alcun problema, senza proteste. Nell’aria un profumo di riso dolce e latte, voglia di andare via e lasciar cadere questa compagine con il suo strano allenatore impassibile con cappellino, occhiali da sole e credibilità da salumiere che usa in modo eccentrico il suo tempo libero. Arrivederci Ballardini, il trequartista Ibson non salva nessuno. Oggi ostenta serenità nel Minnesota, negli States, sfruttando forse i corridoi della dirigenza bolognese di provenienza nordamericana.
Storie edificanti di Salvatori che hanno salvato
Maxi Lopez è uno che corrisponde alla fisionomia del buon gesù, con una sana luce di follia e ottusità negli occhi, e che effettivamente si è incarnato nel presepe di gennaio. Col tempo, a forza di calci contro i mercanti del tempio (salvo poi farli ricontattare dal suo agente, a bocce ferme), vagabondaggi in tutti gli stadi della serie A con l’aria supponente dell’Eletto, tra miracoli e resurrezioni, insomma Maxi Lopez è riuscito, quasi da solo, a incartare una salvezza d’oro per il Catania del presidente Pulvirenti. Lopez all’anagrafe, argentino dalla bella gioventù, con tracce sparse anche nel Barcellona, ha ancora un’età interessante quando, il 7 febbraio 2010, al 63° di un momento di svolta della sua vita, ingaggia un duello in corsa con un difensore brasiliano, André Dias, grosso come una botte, con la maglia della Lazio, ma anche lui arrivato da troppo poco tempo per capire cosa volesse dire la parola Lazio, appena prelevato dal mercato di gennaio. L’Unto argentino e il suo marcatore brasiliano stanno correndo senza freni verso un ragazzino uruguagio di nome Muslera, apparentemente sperduto e con dei guanti a proteggere le mani delicate. I due corrono verso di lui, ma l’oggetto del loro desiderio incontenibile è un pallone che rotola radente l’erba con un effetto malevolo, verso il centro dell’area di rigore: lo ha scagliato sprezzante Mascara, innescato da tal Adrian Ricchiuti.
La Lazio si è fatta infilare sulla sua sinistra, ma nessun cross, nemmeno il più ben confezionato, può diventare pericoloso, se non c’è un centravanti che diventa muro, spigolo, bestia, a seconda della spinta che bisogna dare al pallone per buttarlo in rete. E non basta: bisogna che l’attaccante, prima di tramutarsi in pietra, sia anche cavallo e arrivi a destinazione prima del suo marcatore. Così accade per Maxi Lopez, che diventa un uomo felice. Arriva prima di Dias e trafigge Muslera. Per qualche secondo l’occhio televisivo indugia sul suo sorriso, non certo illuminato dalla grazia della sapienza ma tutt’altro che incredulo. Se lo sentiva, corre da solo guardando gli spalti, guardando nessuno. Nessuno intorno a lui, nessuno davanti a lui, mette le mani dietro le orecchie, perché le urla non sono abbastanza per lui, vuole qualcosa di più, un sentimento, qualcosa di stabile, un amore. Poi compariranno i compagni, gli abbracci e, con questi, anche 11 gol in 17 partite, una forma invidiabile, una donna al suo fianco.
Poi compariranno anche i giornalisti, i rotocalchi, i tradimenti, le panchine, impensabili problemi di peso e una resistenza stoica alle critiche, non certo illuminata dalla grazia della sapienza ma tutt’altro che incredula. Non era un campione, non lo è. È stato un Salvatore però.
Nel 2006/2007, la Serie A vive il suo momento di massima bipolarità, irreale da raccontare e da ricordare. Gli effetti di Calciopoli e la coppa del mondo levata al cielo da Fabio Cannavaro consegnano un campionato inverosimile, straziato dalle retrocessioni e dagli squilibri tra le prime due e tutte le altre. Ma tra le pieghe di eventi eccezionali la polvere continua a depositarsi sui mobili della cucina, i postini portano la posta al contrario dei lattai che non ci sono più, ma questa è la norma e l’Ascoli di Nedo Sonetti è in fondo alla classifica e non sarà certo la coppia Bjelanovic-Paolucci a salvarlo, anche perché Paolucci se ne va alla Juventus e realizza il suo sogno di giocare col suo idolo Del Piero, una partita e basta, prima di consegnarsi all’oblio. Arriva Soncin. Finirà male.
La Reggina è poco più su dell’Ascoli, ma ha dalla sua un signor Rolando Bianchi che entro la notte di Natale ha già segnato 9 gol in 18 partite. Nel girone di ritorno raddoppierà i suoi gol, salverà di fatto la Reggina, pronto a proiettarsi nell’olimpo dei goleador europei, e sarà pizzicato l’anno successivo dal Manchester City. Nulla di più facile per confermare le parole dell’ex presidente degli Stati Uniti Truman, “Metti un debole in alto e lui impazzirà”.
Ma qualcosa succede effettivamente in quest’anno così strano da sembrare un anno parallelo, una sorta di sospensione nell’aria, un dosaggio più basso di una droga potentissima. Al 75° minuto di un Parma-Torino bloccato sullo zero a zero, un cross in corsa del terzino Castellini arriva con effetto leggermente arretrato sui piedi di un diciannovenne italo-americano appena arrivato dalle giovanili del Manchester United. Il terzino Balestri lascia a questo Bambinello molto spazio in area di rigore. Lo stop del Bambinello non è preciso, non riesce come forse avrebbe voluto a incollare la palla al piede, ma il leggero controbalzo mette fuori tempo il suo avversario e tanto basta per conquistare istanti preziosi, ecco uno spostamento leggero del pallone per rubare il momento dell’intervento anche a Franceschini, costretto ora ad unirsi a Balestri nell’inseguimento disperato. La falla che si è aperta è improvvisa e pericolosa, tanto quanto l’alone di inarrestabilità di questo Bambinello. A questo punto, in uno spazio ristretto, in leggero vantaggio su due marcatori, questi deve liberarsi anche del sempre-esperto Oscar Brevi, che però dal centro dell’area gli dà una grossa mano ed esce senza cattiveria leggendo male il suo movimento e consentendogli di indirizzarsi verso il portiere con un rapido cambio di direzione col piede sinistro.
A questo punto la preparazione del tiro sta per consentire il recupero dei suoi cani da guardia, ma ancora una volta il senso dell’anticipo dei momenti di gloria gli fa eseguire in bella coordinazione un tiro ancora di sinistro teso e ravvicinato che costringe Taibi a una respinta imprecisa, la palla schizza dai suoi guantoni alle sue spalle e finisce sotto la traversa, per la gioia del mister Stefano Pioli che ha creduto subito alle qualità di questo ragazzino.
Il Bambinello, Giuseppe Rossi, che ancora Bearzot non avrà chiamato “Pepito”, corre verso la curva a festeggiare quello che, nell’anno dei mondiali vinti, sembra il certificato di nascita di un futuro campione più italo che americano. E invece è solo l’attestato di un semplice Salvatore. Bambinello Giuseppe Rossi. Il Parma grazie ai suoi 9 gol e 4 assist si salverà.
La storia infelice
C’è anche una storia infelice, un caso – più unico che raro, almeno finora – di un Salvatore, anche lui biondissimo, dal viso gentile, misericordioso, eppure tenace, magnanimo, di belle speranze, che però per qualche motivo finirà per rovesciare il bene e trasformarlo in male. Da Salvatore del suo popolo diventa colui che lo condanna.
Succede proprio all’inizio della storia recente della Serie A a 20 squadre, come per simboleggiare una sorta di peccato originale. Nicola Legrottaglie, nel 2004/2005, ha fatto tanta, tantissima fatica per scrollarsi di dosso la fanghiglia della gavetta e una nomea di eterno insoddisfatto, incapace di dimostrarsi all’altezza delle qualità che gli altri vedevano in lui, ma questa non è una storia originale, si conosce bene la materia di cui è fatto Legrottaglie, un concentrato di eleganza in infradito. Ecco che a 28 anni sembrerebbe pronto per la Juventus. Deve solo fare un piccolo passaggio a Bologna, nel mercato di gennaio, nascere in una culla, Salvare la piccola di turno e poi tornare a casa a raccogliere quanto seminato.
Arriva a Bologna, che non è proprio una provincia da poco, blasonata anzi, e guidata da Carlo Mazzone, con il virtuoso Bellucci al fianco di Tare, il campione d’Europa Zagorakis violoncello di centrocampo, Nervo violino sulla fascia e il veterano Pagliuca a caccia di emozioni forti, parando nella sua città. A natale Mazzone aveva rimediato una bella vittoria contro la Reggina e si era sistemato fuori dalla zona retrocessione, ma sempre in apnea. Può bastare solo un ritocco. La squadra riprenderà quota, pensano in molti. E l’unico nuovo arrivato è proprio Legrottaglie, un prestito d’oro dalla Signora Juventus. Non si sa quanto Legrottaglie abbia apprezzato il trasferimento. Si può penare che non ci sia niente di più fastidioso, per un uomo che ha passato tutta la vita a strappare erbacce, di riuscire a diventare per qualche settimana un ricco proprietario terriero e improvvisamente tornare dall’oggi al domani a strappare di nuovo le stesse vecchie erbacce. Questa sorte gli tocca, spazzare l’area, ingaggiare pesanti corpo a corpo, impostare quando si può, saltare più in alto di tutti, tenere la marcatura, strattonare, spintonare, scivolare, per rimediare qualche striminzito punticino, ogni tanto, giusto per non retrocedere.
Non retrocedere sarebbe il minimo per fare bella figura con la Signora. E invece, il Bologna arriva allo spareggio contro il Parma, trascinato per i capelli e in diretta rai, sia all’andata che al ritorno. Legrottaglie è subentrato a Torrisi, infortunatosi nella vittoria bolognese al Tardini. Al ritorno tocca a lui dal primo minuto, al fianco di Gamberini. La storia è celebre e non è necessario allungarla, nel momento decisivo della gara, 1-0 per il Bologna al Tardini, 0-1 per il Parma al Dall’Ara, una manovra di accerchiamento dei Crociati fa pervenire un cross al centro dell’area piccola.
Legrottaglie, coda bionda e fare disinvolto, decide di andare di testa, poi di piede, poi di cuore, poi resta fermo e quando capisce che la salvezza non è la Salvezza, quello che va bene per gli altri non va bene per lui e quando sente, finalmente, che il suo destino si compierà un giorno lontano, lontano nel tempo e lontano anche nello spazio, fuori dallo stadio, fuori dai cori che presto qualcuno inventerà contro di lui, si lascia andare all’indietro, manca il pallone, sente il fresco dell’erba finta del presepe sulla faccia, con l’occhio rovesciato dalla terra al cielo, vede Gilardino segnare il gol che lui non è riuscito ad impedire. Il Bologna retrocede per colpa di Legrottaglie, di fatto. Non importa. Lui ritorna verso il centro del campo. Non importa, pensa. Natale verrà l’anno prossimo.
E oggi?
Oggi, nella grotta si fa fatica a vedere il volto di un Salvatore.
Non sarà facile per il Palermo che abbia i tratti ancora inespressi dell’attaccante Stefan Silva o del rude difensore Sunjic che viene sì dalla Germania, ma dalla seconda divisione. Si gioca qualche chance Acosty, l’unico vero scossone in casa Crotone, un gesù arrabbiato e nero, rapidissimo sulla fascia destra, cuore di serie B, ma sarà davvero così? A guardar bene, però, ad avvicinarsi molto, a restare quasi incollati al suo viso, nelle tenebre glaciali che incombono nella grotta di quest’anno, si riconosce l’espressione cinica e stanca, con l’occhio tremulo dell’ossessione, il corpo freddo senza brividi, i pochi capelli aggrappati a una testa piatta, come la terra prima di Copernico e Galileo. Lo stesso che era sfuggito a Legrottaglie, nel peccato originale.
È Alberto Gilardino, scaricato ingloriosamente dall’Empoli, scelto dal Pescara per affrontare la terribile salita della seconda parte del campionato. È lui, un anno dopo il ritiro di Luca Toni, l’ultimo campione del mondo in attività che ancora sgomita per Salvare qualcosa o qualcuno.