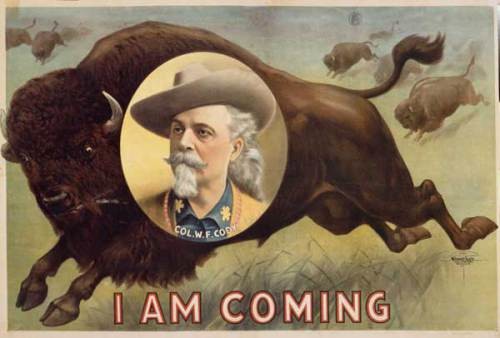Il presagio arrivò in una notte che diventò pioggia, poi diluvio e poi miracolo. La sera del dieci ottobre 2009 Diego Armando Maradona si trovava a Buenos Aires, a pochi passi dalla linea laterale dello stadio Monumental. Alle sue spalle – altrettanto vicina ma allo stesso tempo tanto, troppo lontana – la panchina della nazionale Argentina. Il cielo della tarda primavera bonaerense aveva improvvisamente rovesciato un acquazzone su una partita brutta e arbitrata in modo pessimo. Oltre quella linea bianca, oltre la punta dei piedi di Diego, i suoi giocatori si muovevano a fatica nel fango. Sopra le loro teste incombeva un cielo nero e pericolosamente vicino. Attorno a loro una pioggia scura riempiva l’aria e avvolgeva la luce dei riflettori. E l’Argentina osservava il suo idolo davanti al suo fallimento peggiore.
I giocatori del Perù erano ammassati all’interno dell’area di rigore, per difendere un pareggio che poteva sembrare inutile ma soltanto a chi non conosce il piacere di tirare giù un dio dall’Olimpo e poi ballare sul suo cadavere. I giocatori argentini, frastornati, si guardavano intorno con la faccia sporca e umiliata, schiacciati dal cronometro che segnava il novantaduesimo minuto e dalla responsabilità di aver condannato un allenatore che non avrebbero mai voluto deludere. Soltanto uno di loro non aveva paura della tragedia che si stava abbattendo su tutto il paese sotto forma di diluvio e di pareggio. Un uomo strano, un pazzo totale, un incosciente, l’eroe di un film, il matto del villaggio, carne da cannone, soldato ottimista.
In quella notte di furia primaverile Martin El Loco Palermo, abbondantemente oltre la linea dei difensori e abbondantemente oltre la linea che separa la paura di perdere dalla certezza di vincere, segnò un gol a tre metri da una porta che non riusciva nemmeno a vedere, perché la pioggia era un muro e perché, probabilmente, aveva anche gli occhi chiusi. Pochi secondi dopo, mentre i compagni abbracciavano il pazzo che urlava alle intemperie, mentre Maradona si lanciava a volo d’angelo contro la pioggia, Víctor Hugo Morales prendeva in prestito una frase di María Elena Walsh, consegnandola ai faldoni della storia del calcio: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando.”
Oggi la storia di quel mondiale è nota e abusata. Il tempo, col suo passo lento, ha distorto la memoria convincendoci che andò come tutti si aspettavano, come doveva andare. Ma la verità è che in quell’inverno africano del 2010, prima della tempesta di coincidenze e segnali, erano in pochi a prevedere quale sarebbe stato l’epilogo. Al mondiale Sudafricano, mentre il mondo del calcio che conta si lamentava delle traiettorie impazzite dello Jabulani e avanzava le solite, scriteriate previsioni sull’atteso trionfo del calcio africano, Diego Maradona e la sua Argentina affrontavano le avversarie del gruppo B, sul lato più difficile del tabellone. Vittoria stentata contro la Nigeria all’esordio, poi Corea del Sud e Grecia superate di slancio. Prima di ogni partita Maradona baciava i suoi giocatori, consapevole che al mondiale una benedizione può valere più di una lavagna tattica. Qualcuno, primo tra tutti Carlos Tévez, sembrava un po’ a disagio davanti a questa ingombrante investitura sentimentale. Qualcun altro, a ragione, faceva notare che Maradona non aveva mai dato un’identità di gioco alla sua squadra. Precisazioni buone per i giornali e per i bar. Sicuramente non per le tempeste. Una partita dopo l’altra, l’Argentina giocava male e vinceva. Dicevano che fosse grazie ai suoi campioni e non certo per merito del suo imbarazzante condottiero: sovrappeso, mal vestito, troppo emotivo, poco razionale, incapace di gestire il suo stesso carisma. Scrivevano che l’Argentina di Messi andava avanti ma non convinceva, che Maradona si affidava alla sorte perché non sapeva allenare. E intanto arrivava il 27 giugno, giorno della partita Germania- Inghilterra, nella “città delle rose”, Bloemfontein. Un giorno che oggi, a ben vedere, segna il cammino dell’Argentina di Maradona anche se l’Argentina di Maradona non è scesa in campo.
Il destino calcistico non ama le partite interlocutorie, e fino a quel momento era rimasto sulle sue, da parte. Si svegliò di colpo in quel pomeriggio fresco di fine giugno, in quella città che conserva i modi e gli scorci del colonialismo olandese.
Oggi tutti ricordiamo come sono andare le cose quella sera a Bloemfontein. Al trentasettesimo del primo tempo Upson ha segnato di testa il gol della speranza, apparecchiando la tavola per il primo momento decisivo del mondiale. Un minuto dopo, Lampard ha scavalcato Neuer con un mezzo pallonetto. Il pallone è andato a sbattere sull’erba oltre la linea di porta. Gol netto per tutti gli spettatori e per tutti gli altri davanti alla tv, ma non per l’arbitro uruguaiano Larrionda, immortalato dalle telecamere mentre faceva cenno che no, non era gol, niente rimonta. Poi però qualcosa, una misteriosa interferenza che ancora oggi non ha un nome perché forse non ce l’ha mai avuto, ha sussurrato nell’auricolare di Larrionda che non era così che sarebbe andata. Improvvisamente l’arbitro ha chinato il capo, rassegnato e come circondato da un silenzio impositorio, prima di indicare il cerchio di centrocampo e convalidare il gol. Dal caos di proteste e spintoni è uscita un’Inghilterra galvanizzata, che con la doppietta di Rooney e un paio di parate decisive di David James ha schiacciato una Germania troppo inesperta per reggere la tensione del momento. Il giorno dopo l’Argentina ha superato un Messico abbastanza trascurabile grazie ai colpi di Tévez e Higuain, permettendo a Maradona di sfogarsi malamente con tutto e tutti.
A distanza di cinque anni molti ripetono che la sua sfuriata in sala stampa, suggellata da un microfono decollato dalla scrivania e andato a sbattere contro il ginocchio del malcapitato Salvatore Bagni (presente chissà come e perché), era soltanto un modo per caricare la squadra prima della partita con gli inglesi. Ma la verità è che quel giorno, ancora quel giorno, si è detto e si è scritto che Maradona era stato fortunato a trovare il Messico e che non aveva molte speranze contro l’Inghilterra, superiore a centrocampo e allenata dal maestro Fabio Capello. Anche la famosa frase pronunciata da Maradona alla vigilia – “non posso vincere il mondiale senza battere l’Inghilterra” – fu deliberatamente fraintesa e riportata come un’ingenua tautologia.
Tante volte mi hanno ucciso. La partita del tre luglio, giocata a Città del Capo, non è stata la partita che tutti avevano previsto. È stata invece la partita in cui i segnali smisero di gocciolare e piovvero. È stata la partita dei falli a ripetizione, delle ammonizioni timide dell’arbitro Irmatov, della definitiva uscita di scena Messi, della consacrazione tardiva di Juan Sebastian Verón e del salvataggio sulla linea di Demichelis, con i capelli più che con la testa. Ma soprattutto è stata la partita del gol di Javier Pastore. Un gol che molti hanno paragonato a quello immortale segnato da Diego, sempre contro l’Inghilterra e sempre nei quarti di finale, quasi trent’anni fa, anche se in realtà l’azione di Pastore ha un ritmo completamente diverso, in controtempo. Al trentesimo della ripresa, quando tutti gli altri erano impegnati a difendersi dalla paura del fallimento tirando calci a caso e protestando, Pastore è entrato al posto di uno spento Messi. Due minuti più tardi, dopo uno scontro a centrocampo tra Mascherano e Gerrard, ha preso palla e ha cominciato a scartare gli avversari. Con tunnel, finte di spalla e un passo lento che sembrava non avere destinazione. Saltati Barry, Milner e Ashley Cole, troppo stanchi per rincorrerlo. Triangolo secco con Aguero e tiro a filo d’erba e di palo, dal vertice destro dell’area di rigore. Capello si lamentava per un fallo di Mascherano su Gerrard. Maradona entrava in campo, l’Inghilterra usciva dal mondiale. Oggi quelle immagini hanno perso un po’ vigore, perché Pastore non ha fatto la carriera che ci si aspettava dopo quel gol e perché in fondo quello non era e non poteva essere il suo mondiale. Ma in quel momento, a Città del Capo, lo stadio ha voluto credere di aver rivisto Maradona e che così devono andare le partite tra Argentina e Inghilterra, sempre e per sempre.
Tante volte sono morto. Il sette luglio del 2010, a Durban, la Spagna doveva dimostrare a tutti che l’Europeo non era stato un episodio, che era arrivato il momento di aprire una dinastia del nuovo millennio. Ma a quel punto, dopo aver visto Argentina-Inghilterra, ci credevano in pochi. Gli spagnoli hanno provato a giocarsi l’unica carta che avevano, quella del gioco sporco per far crollare emotivamente Messi e scatenare il caos nello spogliatoio argentino. Titolacci sui giornali, insinuazioni su un presunto problema di alcolismo della Pulga, dichiarazioni al veleno dei suoi compagni del Barcellona. Non ha funzionato, perché Maradona ha deciso (inconsapevolmente, dicono) di proteggere il suo numero dieci tenendolo fuori dalla formazione titolare. L’Argentina ha giocato l’intera partita nella sua metà campo, Tévez ha pagato la sua scarsa propensione alle effusioni con un doppio palo al novantesimo e i supplementiari sono arrivati e passati senza lasciare traccia. La sequenza dei rigori, rivista oggi, è come l’ennesima finestra su un passato sbiadito e sull’umorismo divino. Puyol/Baresi: gol. Heinze: gol. Xabi Alonso/Baggio: gol. Verón: gol. Fabregas/De Agostini: gol. Mascherano: gol. Iniesta/Donadoni: parato. Messi: gol. Villa: parato. Maradona e l’Argentina in finale.
Ma sono ancora qui. Il cerchio si chiude sempre, e il cerchio si è chiuso alle dieci di sera dell’undici luglio 2010, al Calabash di Johannesburg, al minuto novantuno. Ancora uno zero a zero, trascinato fino allo sfinimento. Le tribune piene di giornalisti con il loro articolo pronto e impacchettato attorno al destino che non poteva non compiersi. Una volata di Di María in contropiede imbizzarrito, con il misterioso Giovanni van Bronckhorst che lo abbatte sulla linea dell’area di rigore. L’arbitro poliziotto Webb che decide punizione dal limite, niente rigore. Maradona fuori di sé, espulso per proteste. La punizione di Tévez che rimbalza tra i polpacci e i parastinchi dei giocatori in barriera. La presa difettosa di Stekelenburg. Il pallone impazzito, anzi no, guidato con mano decisa, che carambola tra i difensori e quasi si ferma a un metro dalla porta, proprio lì dove c’è un uomo più grosso degli altri, un pazzo, che il pallone quasi lo manca, lo sfiora appena e lo guarda, stavolta sì che lo guarda mentre rotola oltre la linea. Fischio finale. Mascherano alza la coppa. Gli argentini hanno la faccia di chi non sapeva e adesso sa, e in cuor suo ringrazia. Maradona non c’è, non può esserci. Le telecamere lo cercano e non lo trovano. È negli spogliatoi, da solo. Probabilmente piange, sicuramente prega.
Non è andata come doveva andare, perché niente va come deve andare. Non esiste un disegno, ma solo il sospetto che qualcuno, ogni tanto, si prenda la briga di intervenire per indirizzare la breve traiettoria di un suo figlio prediletto. Uno che è morto e ancora cammina. Resuscitando.