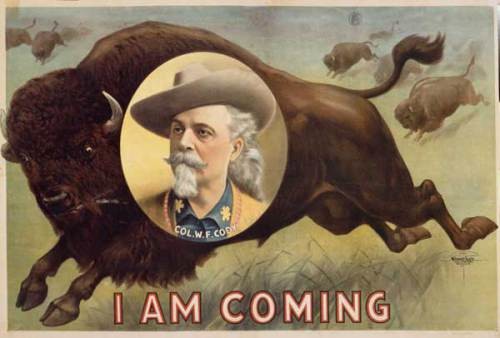I fari della Punto illuminano la strada nella notte senza luna di Torino. La radio trasmette una canzone di David Bowie e la città sembra più deserta del solito. Solamente Gliz e Neve, le due orrende mascotte delle Olimpiadi da poco concluse, lo osservano inanimate dai cartelloni pubblicitari. Una macchina nera, la solita macchina nera, lo segue da lontano. Pessotto sta tornando da Biella, dove ha incontrato il frate francescano che lo aiuta da qualche mese, da quando ha cominciato a svegliarsi la mattina dicendo “cazzo, un altro giorno”. Solamente a lui ha confessato gli incubi mostruosi e le terribili pene che lo tormentano da allora.
In ogni volto che incontravo vedevo il Diavolo o la Madonna. Mi sentivo l’oggetto di una persecuzione, inseguito come il peggiore dei furfanti. Ho conosciuto la paura. Una parola insopportabile da pensare, figuriamoci da pronunciare. L’angoscia del presente e l’incertezza del futuro mi stavano divorando. Senza alcuna apparente ragione, quel dolore scendeva lento ma inesorabile, silenzioso come la neve, implacabile come il tempo, persistente come la pioggia di Marzo. Restavo lì, sulla mia zattera, indeciso sulla direzione da prendere, mentre sentivo il fragore delle rapide sempre più vicino. E intanto non facevo nulla, continuavo a restare in silenzio.
Fermo ad un semaforo Pessotto cerca di fissare la strada di fronte a sé, per non guardare la macchina nera accostata alla sua. Lui sa che all’interno dell’auto ci sono i suoi suoceri che lo osservano. Non sono davvero loro, ma una versione di loro invecchiata di molti anni che aspettano che lui si volti per poterlo guardare negli occhi e dire “vedrai che brutta fine che farai”. Pessotto chiude gli occhi, preme il piede sull’acceleratore e scappa via. Cerca di evitare le strade più trafficate per paura che la Guardia di Finanza lo possa fermare. Accosta ad una pompa di benzina chiusa, per riprendere fiato e bere un po’ d’acqua. Dopo aver bevuto delle lunghe sorsate da una bottiglietta dal distributore automatico si accorge però che le monetine del resto sono cosparse di una strana e sottile polvere bianca, che si attacca come colla alle sue mani e alla sua giacca. Sgomento, getta via monete e bottiglietta, con la certezza che anche l’acqua sia contaminata. Il suo cellulare suona, lo stanno chiamando da casa.
Certo, avevamo litigato. Perché, non succede a qualunque coppia? Eravamo preoccupati della svolta alla quale Gianluca andava incontro, qualche tensione è normale. Non faceva vacanze da un anno e mezzo, ultimamente dormiva poco. Era ossessionato dalla Juventus. Era stressato, soffriva per l’addio al calcio, avrebbe voluto continuare a giocare. E comunque smettere è sempre un momento delicato. Smettere poi in un anno così… Soffriva molto per le inchieste, era più che dispiaciuto. Diceva sempre: “È ingiusto. È come se tutto il nostro lavoro di colpo non valesse più niente”. Ha accettato di diventare dirigente per amore delle Juventus e anche per senso del dovere. L’incarico di team manager che gli avevano dato lo agitava, temeva di non essere all’altezza. Il mondo del calcio fuori dagli spogliatoi gli ha sempre fatto paura. Era andato ad Amburgo a trovare i calciatori della Juventus proprio per il suo nuovo incarico. Ma nel ritiro della nazionale aveva incontrato i vecchi compagni: non deve essere stato facile vedersi dall’altra parte.
La palazzina in corso Galileo Ferraris è illuminata delle prime luci dell’alba. Pessotto parcheggia la Punto poco distante. La misteriosa automobile con la targa di Montecarlo o forse Svizzera che aveva visto il giorno precedente dopo la riunione è sparita. Era arrivato in ritardo a quella riunione, e non gli era chiaro di cosa si stesse parlando. Franzo Grande Stevens bofonchiava molto sommessamente del nuovo assetto societario o forse della conferma di Capello, ma Pessotto era stato distratto da una figura in disparte, come sempre seduta nella penombra. Portava al mignolo un anello d’oro che, con l’altra mano, faceva girare molto lentamente su se stesso. Aveva fissato Gianluca per tutto il tempo, aprendo ogni tanto la bocca e mimando parole che lui non riusciva a comprendere. Miniz era il nome che aveva inventato per lui. Tutti hanno un Miniz, nei propri incubi più inconfessabili. Pessotto stringe forte il rosario. Sistema il cellulare, le chiavi della macchina e il computer palmare con molta cura sul davanzale, davanti all’abbaino. Non si era mai sentito così. Vuoto.
Stanotte Signore, ho sognato di camminare a piedi nudi con te sulla spiaggia. C’erano le nostre orme, sempre affiancate le une alle altre. Camminavo e vedevo, sullo schermo del cielo, i giorni trascorsi. Quelli belli e quelli brutti. Nei momenti di gioia e di serenità, Tu c’eri. In quelli di maggiore angustia, di maggiore paure, di maggiore dolore, mi voltavo indietro e vedevo solo due orme. Dov’eri, mio Signore? Perché mi hai abbandonato? “Sciocco” mi ha risposto il Signore rimproverandomi, “non ti sei accorto che quelle erano le mie impronte e non le tue? Che mentre cadevi Io ti tenevo in braccio? Che Io ti ho salvato?”
Montero lo veglia da nove giorni. È volato dall’Uruguay non appena ha saputo della notizia da una telefonata di Rampulla. Non ha alcuna intenzione di andarsene prima che l’amico sia fuori pericolo e si risvegli. Non si sentivano da anni e probabilmente non erano mai stati davvero amici. Ma compagni sì, e questo è quanto basta a Montero per essere lì. Pessotto “il professore”, o “l’economo”, era amato e rispettato da tutti i compagni. In campo Paolo gli urlava di tutto e lui sopportava sapendo che l’uruguagio aveva solo bisogno di sfogarsi per mantenere la concentrazione. Fuori dal campo parlava poco, ma se aveva qualcosa da dire gli altri stavano zitti. Era l’unico che anche Davids stava ad ascoltare in silenzio. Fuori dall’ospedale i giornalisti si accalcano da giorni per strappare una qualsiasi dichiarazione ad aggiungere alle bugie già raccontate, ma Paolo non parla con nessuno. Seduto nella sedia della sala rianimazione guarda il letto dell’amico, i tubi e fili che lo avvolgono e le macchine che lo tengono in vita. “Forza Pesso, cazzo” dice. Pessotto apre gli occhi e lo vede.
Ricordo gli attimi in cui pensavo di essere morto. Al pronto soccorso, credo, oppure nei momenti di veglia durante il coma farmacologico. Il corpo se ne andava, lo sentivo andare. Sapevo che stavo per addormentarmi e che non mi sarei svegliato mai più. Non potevo parlare perché mi avevano fatto la tracheotomia. Ho trascorso tre mesi come una pianta dentro un vaso. C’era il divieto assoluto di dirmi la verità. Il televisore restava sempre spento, e zero giornali. Volevo vedere il gran premio di Formula uno e le partite dei mondiali. La tele, sempre spenta. Finalmente ottenni di guardare i servizi sulla sentenza di Calciopoli che riguardava la Juve: tutti pregavano che non si facesse cenno alla mia vicenda, e così andò. Ma io sono abituato a smanettare col televideo, così andai alla pagina delle notizie sportive e lessi la mia. Stranissimo: la notizia parlava delle mie condizioni fisiche, non del fatto. Il professor Donadio, il primario di rianimazione, usava una curiosa metafora sportiva per spiegare come stessi. Diceva che è come essere arrivati quasi in cima alla salita, si vede il traguardo però la strada resta insidiosa e piena di curve. Perciò mi convinsi di essermi schiantato in auto. Tutti mi parlavano di macchine, così credevo davvero di avere avuto un incidente. Ogni giorno c’era il colloquio con lo psichiatra. Siccome mi ritengo una persona di media intelligenza, un piccolo dubbio affiorava. Voglio dire, mica mi mandavano l’ortopedico. Pensavo: o mi sono schiantato in auto, oppure ho fatto qualcosa di brutto. L’ipotesi c’era, una su due, non si scappava. Così, presi coraggio e chiesi: “che ho fatto? Cosa mi è successo?” La risposta è stata “l’hai fatto tu”.
È accuratamente avvolta in un asciugamano dell’hotel Regent di Berlino e in una bandiera tricolore, chiusa dentro una borsa da viaggio in pelle. L’hanno trasportata a turno Zambrotta, Cannavaro e Ferrara, dato il peso non indifferente di 6 kg e 167 grammi. Sono dovuti entrare da una porta laterale e salire al quarto piano attraverso un montacarichi, data la presenza di più di tremila persone che aspettavano nell’ingresso principale dell’ospedale. I malati che li hanno incontrati nel corridoio li hanno abbracciati e ringraziati. Qualcuno ha anche intonato uno stonato “po po po”. All’ingresso della sala rianimazione, con i camici bianchi e quel sorriso sui volti sembrano davvero tre angeli scesi dal cielo, pronti per un’annunciazione divina. Portano un dono all’amico. La bandiera italiana con la scritta “Pessottino siamo con te” si srotola e la Coppa del Mondo luccica più del Santo Graal. A Pessotto sale improvvisamente la febbre a 40°.
Sono come un astronauta tornato da un viaggio fantastico e un po’ mostruoso. È stato un viaggio nel paese del dolore. Gli alieni stavano per divorarmi, invece sono ancora qui. Sono tornato per benedire ogni giorno in più che respiro. Però diverso, cambiato. Mi curo, sono in analisi, lavoro su me stesso e non me ne vergogno. La felicità si rivela solo attraverso abissi di dolore, e più a fondo ti scava, più gioia puoi contenere. È come quando percorri i trenta metri verso il dischetto del rigore, solo che se sbagli il tiro muori. Ma se invece fai gol, la carica che ti resta dentro è enorme. Ci penso spesso? No, ci penso sempre.