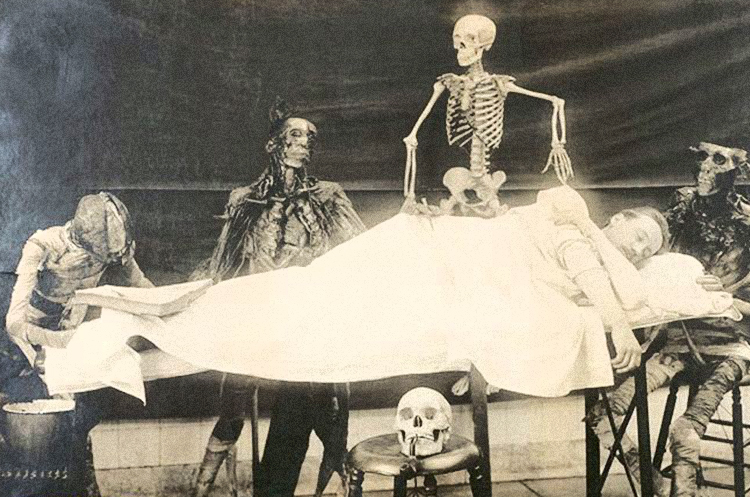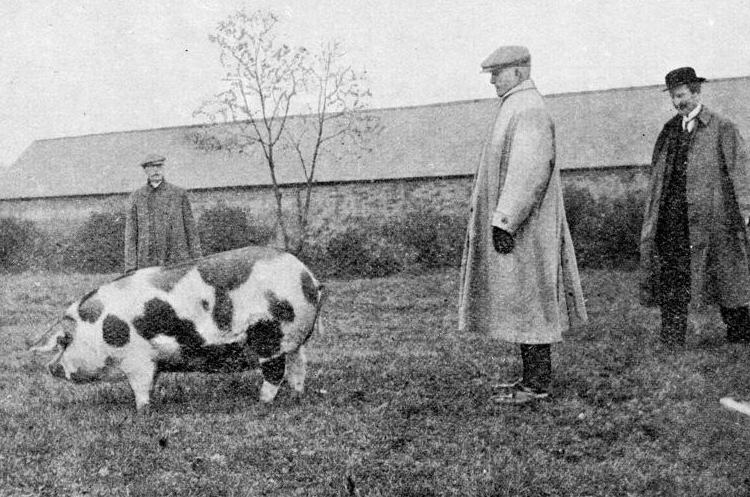Non è bello essere comandanti nel deserto, senza un esercito né un grande nemico da affrontare. Ma una duna è pur sempre un paesaggio e tanto vale poterci salire per vedere se all’orizzonte non si palesi per caso, un giorno o l’altro, un mercante di schiavi, una donna o una preda buona da accoppare. Insomma, costruirsi attorno un bel castello di cazzate, sempre più vasto e architettonicamente caotico, i cui corridoi e stanze contengano solo oggetti nel posto sbagliato al momento sbagliato. Giganteschi e dettagliatissimi affreschi, capitelli barocchi, immensi lampadari di cristallo e arazzi vari. Un cumulo di cianfrusaglie, teorie del complotto, ingarbugliatissime tesi sulla storia, l’intera storia, di dio e dell’uomo. L’essere umano e il singolo, la ricostruzione psicologica dei traumi dell’infanzia, da quella volta che il padre ha punito sonoramente per un passaggio sbagliato a quella in cui era troppo buio per giocare ancora a pallone in strada e non si è rientrati al richiamo della madre. La madre di quell’unica grande donna che è la terra, pronta a dare a tutti i suoi doni: spesso il deserto o una sconfinata distesa di ghiacci. A tutto questo deve pensare l’attaccante ogni volta che entra in area affiancato da un killer psicopatico, che vorrebbe vederlo soffrire all’infinito piuttosto che morto all’istante, a furia di calci negli stinchi, gomitate nello sterno e pugni nei reni. Un compagno di vita che lo maltratta in continuazione da quando, a un semaforo rosso, con lo sguardo torvo gli ha chiesto: “che cazzo vuoi?”.
Era l’inizio della corsa, anche se l’attaccante ha cercato di risolvere la questione evitandola, innestando la retromarcia, prendendola larga sulla fascia, scaricando dietro per un centrocampista disinteressato ai cazzi della prima linea, facendo un movimento in favore di qualche altro spericolato incursore incurante delle insidie che può nascondere l’abbandono della vecchia strada. Non sa quello che trova l’attaccante in area, una selva di gambe, e poi un parolaio che con la telepatia cerca di ricordargli quando negli esordienti sbagliò il gol e a fine partita fu costretto a subire l’umiliazione della rissa tra il padre e l’allenatore, che lo redarguiva per il suo comportamento in tribuna. Uno di quei parolai con i guantoni da chirurgo, che dopo l’operazione di salvataggio a costo di una cicatrice indelebile nella coscienza dell’attaccante, gli urla in faccia il suo odio verso dio per averlo lasciato così a lungo solo in mezzo a un’area di rigore, dentro la quale non gli è permesso cogliere il frutto desiderato del vero calcio, quello giocato con i piedi. Fuori dalla quale gli è impossibile usare i propri poteri, a meno che non voglia essere punito da leggi fallaci e profondamente ingiuste, o peggio dalla velocità di certe bestie di cui non conosceva l’esistenza prima di uscire da quel giardino dell’Eden. Una gabbia dorata. Non si sta male in carcere. Infondo ha tutto ciò che gli serve per restare in vita: una scorta di borracce e una sciarpa con i colori giusti nel caso faccia freddo o serva un biglietto da visita. A volte la provvidenza lo ha dotato di un cappellino per proteggere il prezioso dono della vista dal sole, che gli altri possono godere pascolando liberamente qua e là. Anche se molto più spesso è coperto dall’ombra della tribuna al pomeriggio e da una fitta coltre di nebbia e fumogeni la sera. Per non parlare del muro di sputi dei detenuti comuni del piano di sopra, pronti a sommergerlo appena si avvicina al raccattapalle. Ma finché si trova all’interno dell’area piccola, finché si trova all’interno di quello spazio ristretto con la sua scorta di borracce e la sua sciarpetta appesa al palo, si potrebbe quasi dire che fila tutto liscio. Basta che non prenda quel frutto, basta che non giochi a calcio come fanno tutti gli altri, che non abbia una vita vera. Deve usare solo le mani. Come da piccolo, quando era lo sfigato che giocava a pallavolo.
E certo non può dimenticare l’astio verso dio e verso l’attaccante. Quella bestia a cui è stata concessa dalla provvidenza la possibilità di entrare e uscire quando vuole dalla gabbia dorata dell’area. Appena lo vede non manca di ricordargli i suoi difficili rapporti con i compagni di squadra, con i genitori vecchi e incazzati perché a dispetto dei lauti guadagni ancora non hanno potuto godersi la villa sul lago, con il fratello che ha preferito studiare per fare un lavoro serio e lo considera un imbecille. L’attaccante sa che guardare troppo negli occhi il portiere potrebbe significare tutto questo, e quindi anche il doversi porre seri interrogativi sulla propria vita. Come ad esempio il motivo per cui due ore prima era troppo concentrato sulla scelta dell’abbinamento tra i due scarpini (blu elettrico e fucsia o blu acquamarina e giallo) per ascoltare l’interminabile sermone dell’allenatore, che magari più avanti sarebbe tornato utile, gli avrebbe evitato di giocare con le continue urla di rimprovero nelle orecchie. E perché quel rimprovero gli ricordava ogni volta il volto di suo padre al primo passaggio sbagliato. L’aveva minacciato di prenderlo a cinghiate. E perché non ci aveva pensato prima? Poteva mettere incinta la soubrette calcolando il calendario, facendo in modo che i nove mesi scadessero ad agosto, invece che dover affrontare la trasferta di 700 kilometri a Frosinone, con il dubbio che il suo erede nasca proprio durante il ritorno in aereo, con smarrimento del bagaglio.
È meglio non pensare a quanto si è stupidi mentre si è in area, ed evitare quel represso del portiere che cerca di trascinarlo nel suo disagio esistenziale. Tuttavia quello sguardo fugace gettato verso la porta non può far dimenticare il compagno di vita al suo fianco, con la pistola e i tacchetti puntati verso il suo ginocchio. Perché tanto odio da parte di uno che abita l’area come un albergo a ore e preferisce non parlare col portiere o a farlo dandogli le spalle? Che gliene frega? Non è che a questo punto conviene liberarsi di lui piuttosto che segnare? Si può anche cadere nella vita, con dignità. Pare che alle donne non faccia più così schifo il fallimento, perché no? Elogio del fallimento. Un tuffo nell’abisso, anche solo per finta, e il poveretto saluterebbe la compagnia mestamente, senza neanche esprimere il suo ultimo desiderio, magari addirittura prima che gli rompa un ginocchio. D’altronde è sempre una questione politica: il difensore sta davvero cercando di ammazzarlo, ma se denunciasse la cosa prima che accada, di cosa potrebbe sentirsi colpevole? Le leggi parlano chiaro: se fosse accusato sarebbe più probabile che un processo lo subisca comunque. Male che vada ci rimedierebbe un giallo l’attaccante, l’onta della vergogna. Ne ha già accumulata tanta in vita. E poi al giorno d’oggi la gente dimentica in fretta. Oltretutto, se decidesse per il tiro, non è escluso che una zolla, un filo d’aria di troppo, la rugiada o il gesso della linea deviino il pallone nella direzione della vergogna. La vergogna in ogni caso. Tuffandosi invece, oltre che liberarsi da uno scomodo matrimonio tenuto insieme dall’odio reciproco, avrebbe la possibilità di aggiustare le cose con calma, dal dischetto, con un tiro comodo, senza rompipalle nei paraggi, fatto salvo per quel sociopatico in porta.
Certo, la possibilità di sbagliare e di incappare in una fase di crisi dei trent’anni non sarebbe comunque esclusa. Le cose potrebbero complicarsi ancora. Il peggiore dei casi è questo: simulazione, l’arbitro ci casca, il difensore viene espulso come da regolamento. L’attaccante sbaglia il rigore, si innervosisce per il bagaglio smarrito e per la moglie che sta per partorire, oltre che per il rapporto col fratello saccente. Viene sostituito perché non ne prende più una. Infine la squadra non riesce a sfondare il fortino difensivo e magari perde anche in contropiede. Poi mentre in sala parto si completano le operazioni, la tv del bar dell’aeroporto trasmette le immagini della simulazione e alcuni individui panciuti e stempiati azzardano dei giudizi morali sulla condotta dell’attaccante. Arrivato in ospedale la moglie, prevedibilmente, è incazzata per la sua assenza alla nascita del figlio. La macchinetta delle merendine ruba l’euro e in sala d’attesa c’è un “amico” della moglie, mai visto prima, ansioso di vedere il bambino. Ecco, forse è meglio tirare, vaffanculo. Come tirare la cocaina alla festa, in città, è un segno d’amicizia: e no amicizie, no partnership nella società che aprirà la discoteca vicino alla fermata metro Romano.
O forse, più semplicemente, bisognerebbe affidare tutto alla statistica: è più probabile che vinca una squadra il cui attaccante abbia provato a tirare o una il cui attaccante abbia provato a far restare gli avversari in dieci? Ma di fronte all’imprevedibilità degli eventi la statistica non è sufficiente: cosa succederà dopo la rivoluzione? Molto probabilmente vi sarà un periodo ancora peggiore. Basta questo per assopire il desiderio di cambiamento? A tutti questi profondi interrogativi l’attaccante deve pensare eccome, sebbene possano sembrare superflui. Ci deve pensare. L’unico testo di filosofia di cui ricordi qualcosa dai tempi del liceo è Il Principe di Machiavelli. Per anni lo ha confuso con Il Piccolo Principe, un errore nel quale ha promesso di non ricadere. Il fato non è prevedibile se non, forse, da quel signore supremo contro il quale il portiere spesso inveisce. La fortuna può essere favorevole o avversa, ma fuori da queste forze incontrollabili, vi è spazio per la virtù. L’attaccante deve domandarsi: “io ho virtù?”.
La risposta è no. Non è lui a vivere in una gabbia dorata. Sa benissimo che fuori da lì la vita è molto peggiore, i passaggi e i comportamenti devono essere tutti perfetti e alla giusta velocità, pena essere sbattuti in panchina senza troppi ripensamenti. Lui è uno dei pochi che può penetrare l’area di rigore quando vuole, anche contravvenendo alle leggi umane del fuorigioco. Sa benissimo che, quando si trova lì, è la sua occasione: bisogna razziare il più possibile, perché chissà quando ricapiterà. Un vantaggio che non è da tutti, quello di poter arrivare al cuore della ricchezza, quel fortino difeso da barbari tagliagole con il volto di Paolo Montero , Jihadi John o qualche guardia anti-terrorismo iper-tecnologizzata, all’interno del quale è possibile scommettere alla cieca sui propri sogni prima che una bolla immobiliare arrivi senza preavviso a precisare che si trattava di allucinazioni, pura speculazione. Prima che la bolla arrivi, prima di essere ceduto nella prossima finestra di mercato, l’attaccante sa che deve depredare il più possibile il fortino. Il suo futuro non è quello del grande capitalista, dello sceicco.
Per sopravvivere diventa cinico, disilluso, al punto da fare ampi cenni con la mano diretti alla fiera-Barone, giovane declassato dall’alta società, illuso dall’attaccante di poter ancora diventare una bestia della sua stessa razza, di poter segnare, di poter entrare nel regno della gloria. L’attaccante invita quella bestia sgraziata, un Nocerino di razza impura, come esca per il portiere, per poi abbandonarla il prima possibile in un luogo dove non è in grado di sopravvivere, fuori dal suo habitat, col vestito sbagliato e senza coperta. Niente gloria, niente più contratto: fuori dall’Eden, fuori anche da tutto il resto. Se è sfortunato dovrà accontentarsi di qualche ammortizzatore sociale, stando sotto la soglia di povertà, allestito presso l’Equipe Romagna dei giocatori svincolati. O peggio, per sopravvivere, affidarsi a qualche giro di droga o di scommesse. L’attaccante che entra in area affiancato dal tagliagole, invece, così proprio non ci vuole finire. Per questo la sua soluzione è fare per sé, usare i compagni come un mezzo, se necessario ingannarli con un applauso per un lancio sbagliato o un abbraccio nel copione di un’esultanza programmata.
Così l’attaccante che varca i cancelli della gabbia dorata ha pensato e deliberato: non ha virtù, è diventato un cinico. Da quella prima volta, non vi è più motivo di ripetere il ragionamento. C’è un ordine di priorità semplice e chiaro: se è possibile, il gol lo faccio io; se non è possibile, cerco il rigore e l’espulsione del difensore; se nessuna delle prime due cose è possibile, la passo all’accorrente fiera-Barone, magari un passaggio lievemente troppo lungo per non aiutarlo troppo. Ma neanche facendo un errore evidente, perché la catastrofe individuale è un sottoinsieme della catastrofe collettiva, la quale significa svalutazione del cartellino e ribasso del prossimo stipendio.
Poi un bel giorno, la crisi dei trent’anni arriva comunque, e come sempre con qualche mese di anticipo. Un nuovo allenatore, più giovane dei precedenti e con buon gusto nel vestire, lo obbliga ad aiutare la squadra tornando fin nella propria area. Lo chiamano “il tecnico”. L’attaccante non aveva mai immaginato che potesse esisterne un’altra, di area, né che fosse custodita dalla stessa specie di uomo irrealizzato che si è sempre trovato a dover guardare negli occhi. Ora sono cazzi.