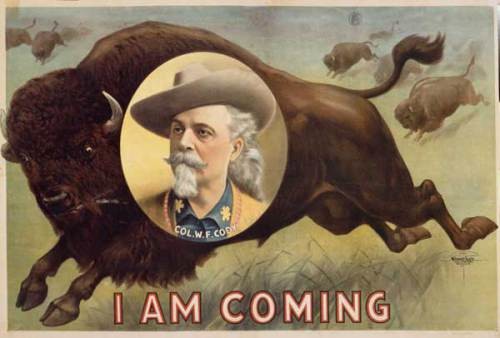È finita. In una notte bollente a Chennai, in India, chi l’avrebbe mai detto?
Rigore segnato, perfetto. Ripetere. Rigore nello stesso angolo, o quasi, sbagliato. Espulsione. Per Marco Materazzi non è una novità. In una singola partita, giocata in stereofonia da allenatore e giocatore, suona lo spartito di una intera carriera, nella quale al rigore segnato e alle coppe alzate fanno da controcanto il cartellino e le lunghe giornate di squalifica, passate incredulo a guardare i compagni sopravvivere senza di lui.
La storia di Materazzi non si legge dattilografata nelle statistiche, quanto nelle sensazioni, nelle facce spesso insanguinate, nei polpacci tumefatti e nelle ginocchia doloranti, nel balbettante sproloquio degli insulti proferiti e subiti dai tanti avversari.
Dove finisce il piacere e dove inizia il dolore? È questa la domanda da porsi, sempre che si sia abbastanza spietati verso sé stessi, sempre che si abbia il tempo di fermarsi a pensare, sempre che si sia disposti ad ammettere che Materazzi rappresenta il calcio italiano degli ultimi decenni meglio di chiunque altro.
Quelli delle vittorie di Marco Materazzi sono stati anni terribili, anni che ci lasciano interdetti e pieni di interrogativi sulla natura del calcio.
Materazzi chiude allenando Alessandro Nesta, uno dei più grandi difensori della sua generazione, rispetto al quale ha vinto molto di più. Quasi sempre, quando in nazionale Nesta si rompeva (proprio come nella ultima partita di Indian Super League), Materazzi ne prendeva il posto, facendo venire i brividi ai tifosi. Ricordiamo il terrore quando la palla arrivava dalle sue parti: rigori causati, espulsioni, la vergogna di passare grazie alle sue scorrettezze. Quando abbiamo dovuto tifare per lui, Materazzi ci ha costretti a confrontarci con il nostro lato più basso. Ci ha costretti a chiederci se sia più importante vincere ed essere odiati, o uscire con dignità fra gli applausi. La risposta è scontata, e non sta scritta nei tomi del codice etico di qualche allenatore fallito.
Materazzi la domanda non se l’è mai posta. Ci ha costretti con le sue vittorie ad amarlo, girando la testa davanti agli sfottò e al biasimo del resto del mondo. In un’ottica romantica potremmo vedere la parabola del giocatore senza grandi mezzi tecnici, in grado di vincere il mondiale e prevalere con ogni espediente su campioni come Zidane. Potremmo, come molti, far riferimento al calcio di provincia, o al periodo inglese, nell’Everton, nel quale avrebbe imparato un calcio fisico, duro, ma leale. Ma così non faremmo che assecondare il luogo comune che avvolge come un’armatura calciatori come lui o Gattuso: l’idea che un breve periodo nel calcio anglosassone gli abbia insegnato ad essere rudi ma corretti. Potremmo riascoltare le parole su “l’uomo vero”, sui grandi campioni dentro e fuori dal campo, sugli “attributi”. Palle, appunto.
Magari potremmo soffermarci invece sul baraccone, sul fenomeno sociologico di una generazione di giocatori tatuati e pacchiani, batacchi delle campane mediatiche con i loro exploit dentro e fuori dal campo, figli del Grande Fratello. I calciatori capaci di spingere la coscienza di un amante del calcio ai limiti, con gesti inediti, mai osati prima sul rettangolo verde ed amplificati da Youtube, dai fotomontaggi e dai comici scarichi, le cui battute e imitazioni ci hanno aiutati a normalizzarli, ingoiando a grandi bocconi sbobbe disgustose.
Ma come detto, non sono qui le risposte che cerchiamo. Quelle nascono nei campetti sui quali tutti abbiamo giocato, e risiedono nel profondo e quasi inspiegabile desiderio di prevalere sugli altri, di dominarli, di umiliare e distruggere il bello, incarnato da chi ci è superiore, tecnicamente e moralmente. La mano in faccia al piccolo funambolo, il calcio sugli stinchi a quello più veloce.
È difficile rimanere indifferenti al dolore. Eppure è impossibile non sorridere con compiacimento, scandalizzarsi e al contempo provare un certo piacere, perverso, nel vedere i tacchetti affondare nella schiena. Nello sguardo invasato di Materazzi che si fa abbattere da una testata di Zidane, è scritta tutta la storia di questi anni. Non si tratta di anni diversi dagli altri, e non vi è nostalgia per un periodo passato, per un’innocenza perduta. Si tratta degli anni, piuttosto, dell’apogeo di qualcosa di molto antico, che chiunque segua il calcio italiano conosce bene. Anni culminati con il mondiale del 2006. Grande vittoria, grandissima vittoria. Un’ultima discesa dei barbari sul calcio, prima dei ricami spagnoli e delle fanfare teutoniche. Un’ultima vittoria dei più deboli, brutti sporchi e cattivi, sui più forti, belli raffinati e intelligenti.
Riguardando quei momenti appare evidente che i nostri non sanno nemmeno come esultare. Si muovono goffamente, fuori tempo, al centro del campo. Totti si avvolge la testa nella bandiera, come una befana. Qualcuno taglia i capelli a Camoranesi. Gattuso è senza scarpe, coi piedi gonfissimi e doloranti. Tutti, con le mani ancora impiastrate di sudore e capelli neri e setosi, baciano la coppa con troppo ardore, come amanti impazienti, incapaci di godere dei preliminari, lanciati come caproni verso le mutande della propria fidanzata.
E dietro a tutti spicca lui, il più alto, con un ridicolo cappello a cilindro tricolore che nessuno sa da dove sia spuntato fuori. È davvero felice? La fotta ha trovato il suo appagamento nella vittoria?
Non sembra esserci piacere, ma solo dolore, nei suoi gesti sgraziati. Che siano elevazioni incredibili, nelle quali sembra trasformarsi in una catapulta, o rigori perfetti, in cui tutto il peso della gigantesca gamba lascia partire una fiondata dal piede sinistro, l’impressione è sempre quella di un vecchio e sproporzionato macchinone scassato. Una specie di armadio con due scope attaccate, che terminano in dei ferri da stiro. Un infernale aggeggio, pesantissimo e letale.
Materazzi non è un guerriero, come si descrive nel titolo del suo libro.
Materazzi, come molti di noi, è intimamente convinto di essere un martire. Di fare il male per perpetrare il bene. Lui è disposto a sacrificarsi, a incarnare la bassezza di tutti, compagni e tifosi, per liberarli dalla loro cattiveria.
Materazzi è il compagno di scuola che fa casino e si fa cacciare, perché tutti gli altri possano approfittare dei pochi minuti di caos, generati dalle sue scenate, per passarsi il compito in classe. Materazzi è il bullo che un giorno ti prende a schiaffi e quello dopo ti difende dal bullo di un’altra scuola, per attaccamento alla maglia.
Materazzi non ride né sorride, quando vince. Più spesso piange, come quando punta il dito al cielo dal quale è sceso dopo il gol nella finale mondiale, o abbraccia Mourinho dopo la vittoria della Champions. Non c’è niente di comico nella ripetizione infinita della testata di Zidane. C’è un’eco che rimbomba nella cavernosa cassa toracica del difensore. Una voce lontana. Il monito di un dio cieco e crudele che ci ricorda che siamo nati per soffrire, e affondando i tacchetti ci ripete: “il calcio non è uno sport per femminucce”.